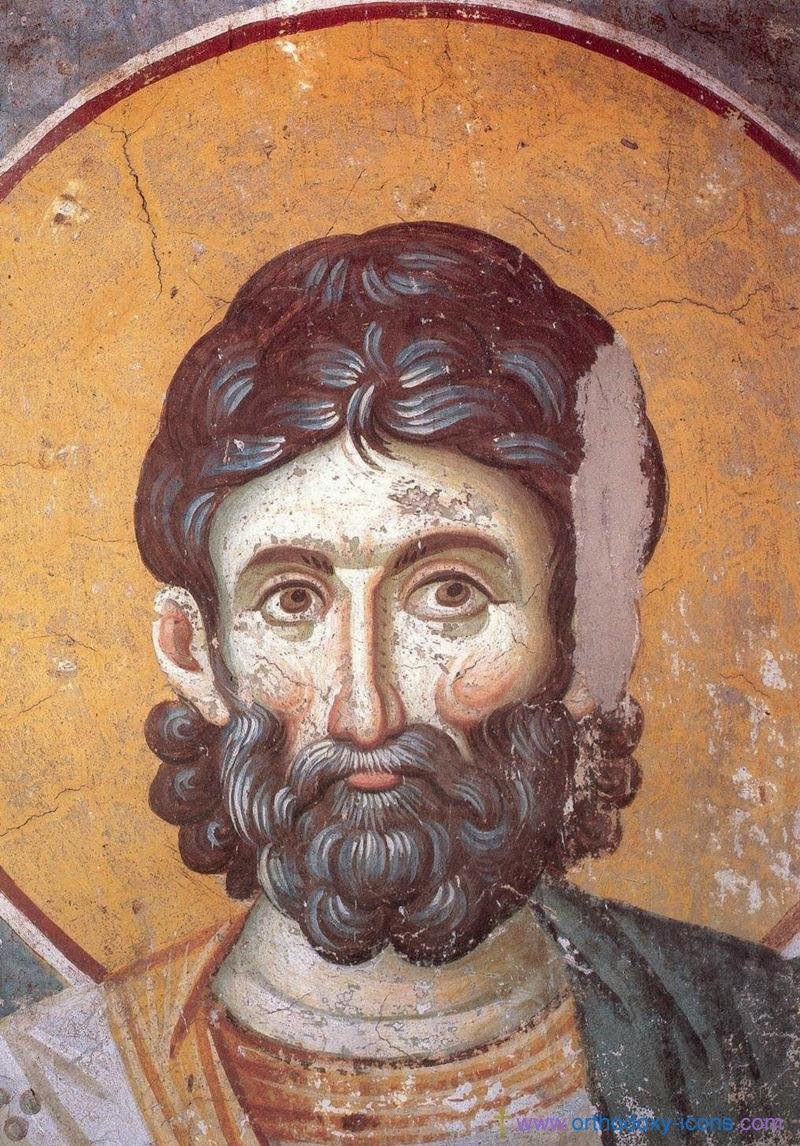Santa Caterina d'Alessandria e Ipazia
Santa Caterina d'Alessandria
Santa Caterina d'Alessandria
La prima passio che riferisce le
vicende della sua vita è piuttosto tarda e risale all' XI secolo.
Nata nel 287 in una famiglia nobile e
agiata, rimase orfana di entrambi i genitori in giovane età,
cresciuta indipendente e nella possibilità di
scegliere la propria vita, si dedicò allo studio, circondandosi di
sapienti ed eruditi, diventando dottissima soprattutto nella
filosofia e nella religione. Era, oltre che di grande ingegno, una
giovane bellissima, richiesta in sposa dagli uomini più importanti
della città d'Alessandria.
Nel 305 Massimino Daia,
insignito da Galerio del titolo di Cesare, fu investito del governo
della Siria e dell'Egitto.
Giunto ad Alessandria,
Massimino Daia ordinò di sacrificare animali agli dei. Caterina,
seguita dallo stuolo dei suoi sapienti, regalmente vestita e nel
fulgore della sua bellezza, gli si presentò davanti, contestandogli
il diritto di fare una simile imposizione e esortandolo a riconoscere
invece Gesù Cristo come redentore dell’umanità. Massimino,
soggiogato dalla grazia di Caterina, decise che la donna sostenesse
le sue idee davanti a una commissione di cinquanta filosofi
alessandrini.
Ma nel corso di questo
incontro Caterina, oltre a controbattere i loro ragionamenti, riuscì
a convertirli in blocco alla fede cristiana. Per questa conversione
così pronta, Massimino li fece immediatamente mettere al rogo. Poi
richiamò Caterina e le propose di sposarla. Dinanzi al netto rifiuto
della Santa ne ordinò la fustigazione ma ella persistette nel
rifiutare le nozze ribadendo la sua fede in Cristo suo sposo. Allora
Massimino ordinò che fosse sottoposta al supplizio delle ruote
dentate ma gli uncini e le lame si piegarono sulle tenere carni di
Caterina, le ruote s'infransero e la Santa non ebbe la minima
scalfitura.
Caterina fu allora
imprigionata e tenuta senza mangiare e senza bere ma una colomba
bianca le portava ogni giorno ciò di cui aveva bisogno, tanto che,
quando la prelevarono da quell'orrido carcere, stava bene come quando
vi era entrata. Allora Massimino dispose che venisse decapitata.
Quando la spada del carnefice spiccò la testa dal suo collo, dalla
ferita, anzichè il rosso sangue sprizzò invece olio miracoloso (1). Dio
non permise che il suo corpo venisse deturpato e una schiera di
angeli ne prese le spoglie e ricompostele le sollevò in volo
andandole a deporre sul monte Sinai, dove ancora oggi l’altura
vicina a Gebel Musa (Montagna di Mosè) è chiamata Gebel Katherin.
Agli inizi del IX secolo, i monaci del monastero fondato nel 328 da
Sant'Elena ai piedi del Gebel Musa ritrovarono i suoi resti e li
traslarono nella chiesa del monastero che venne ridedicato alla
Santa.
Santa Caterina d'Alessandria
Basilica di S.Lorenzo fuori le mura, seconda metà dell'VIII secolo, Roma
Quasi coeva al ritrovamento
dei resti della Santa è la sua prima raffigurazione conosciuta, testimonianza del culto a lei tributato: la santa compare infatti accanto
a S.Andrea, S.Giovanni evangelista e S.Lorenzo in un affresco
rinvenuto nella basilica romana di San Lorenzo e riferibile alla
seconda metà dell'VIII secolo. Della figura della santa si è
conservata solo parte del volto e la parte superiore del corpo ma è
identificata esplicitamente come S.Caterina dalla didascalia che
corre in verticale. Un'iscrizione posta alla base dell'affresco ne
ricorda il committente (Iohannes qui Maximus pr[es]b[iter]
et monachus) e l'autore (Crescentius infelix pictor).
Ipazia
Nata ad Alessandria,
probabilmente nel 370, fu allieva e collaboratrice del padre, il
filosofo, matematico e astronomo Teone (non è invece noto il nome
della madre) di cui proseguì gli studi. Fin dal 393 risulta a capo
della comunità scientifica alessandrina, erede del Museion
fondato da Tolomeo I nel 305 a.C. e distrutto insieme alla famosa
Biblioteca nel corso della guerra tra Aureliano e la regina Zenobia
(270 c.ca).
I cosiddetti Decreti
teodosiani – emessi tra il 391 ed il
392 in attuazione dell'Editto di Tessalonica del 380 che riconosceva
il Cristianesimo come religione di Stato – avevano decretato la
soppressione dei culti pagani e la chiusura di tutti i templi ad essi
dedicati. Ad Alessandria il vescovo Teofilo era riuscito a farsi
assegnare il tempio di Dioniso per trasformarlo in chiesa. Questa
decisione scatenò la ribellione dei pagani che si scontrarono nelle
strade con i cristiani, dopo che questi ultimi avevano malmenato,
torturato e ucciso i sacerdoti del tempio di Dioniso. I pagani si
asserragliarono quindi nel Serapeo e, sotto la guida di Olimpio - il
sacerdote del tempio – che li esortava a morire piuttosto che
rinnegare la fede dei padri, si prepararono a resistere all'attacco
della guarnigione imperiale e dei fanatici cristiani agli ordini del
vescovo. Nonostante lo stesso imperatore Teodosio scrivesse a Teofilo
chiedendogli di concedere il perdono ai pagani, questi ordinò il
loro massacro e la distruzione del Serapeo.

Il vescovo Teofilo, con il Vangelo aperto nella mano sinistra e la destra alzata, poggia i piedi sulle rovine del Serapeo al cui interno si riconosce la statua della divinità per il caratteristico modius che porta sulla testa.
Miniatura tratta dal Papiro Goleniscev, redatto ad Alessandria d'Egitto probabilmente ai primi del V secolo e contenente una Storia del mondo, folio VI verso B.
Non è noto l'atteggiamento
tenuto da Ipazia durante questi eventi, nè i rapporti che
intercorsero tra lei ed il vescovo. La fama di Ipazia e
l'affermazione del suo prestigio intellettuale – che si tradussero
anche in influenza politica – cominciarono a crescere infatti
immediatamente dopo il verificarsi di questi drammatici fatti.
Nel 412, alla morte di
Teofilo, gli successe sul trono episcopale il nipote Cirillo che
prese a dominare la cosa pubblica oltre il limite consentito
all’ordine episcopale entrando in conflitto con il prefetto
imperiale Oreste.
Raffaello Sanzio, La Scuola di Atene (particolare)
Stanza della Segnatura, Palazzi apostolici, Città del Vaticano
1509-1511
Secondo alcuni autori in questa giovane stante e biancovestita Raffaello avrebbe raffigurato Ipazia
Nel 414, durante
un'assemblea popolare, alcuni ebrei denunciarono al prefetto quale
seminatore di discordie il maestro Ierace, un sostenitore del vescovo
Cirillo, che fu arrestato e torturato. La reazione del vescovo fu
durissima: espulse tutti gli ebrei da Alessandria, confiscandone i
beni e trasformando in chiese le sinagoghe. Oreste, per quanto
indignato, non potè prendere provvedimenti contro il vescovo poichè
il clero era soggetto soltanto al foro ecclesiastico.
Un folto gruppo di
Parabolani (2) circondò il carro del prefetto mentre passava per le
vie di Alessandria ed iniziò ad insultarlo finchè uno di loro, un
certo Ammonio, non scagliò una pietra che colpì in testa il
prefetto. Ammonio fu arrestato e torturato a morte nel corso di un
regolare processo.
Cirillo rispose
facendo trasportare il corpo di Ammonio in una chiesa e lo elevò al
rango di martire, come se fosse morto per difendere la sua fede.
L'assassinio di Ipazia
maturò nel pieno del conflitto tra il prefetto ed il vescovo. Ipazia
era infatti uno dei più ascoltati consiglieri di Oreste con cui si
incontrava molto frequentemente. Oreste era riuscito anche ad
ottenere dal prefetto del pretorio Antemio – che teneva la reggenza
dell'impero d'Oriente durante la minore età di Teodosio II – che
fossero riassegnati alla scuola di Ipazia i sussidi governativi
sospesi da un precedente decreto caldeggiato da Cirillo.
Il vescovo, da questo
momento, cominciò a tuonare ogni giorno dal pulpito della cattedrale
cristiana del Cesareion contro questa donna che non la
smetteva di dedicarsi ai numeri, alla musica e agli astrolabi. Nel
marzo del 415 un gruppo di parabolani, guidati da un predicatore di
nome Pietro il Lettore, assaltarono la lettiga che riportava Ipazia a
casa e la trascinarono nella cattedrale. Qui Pietro il Lettore la
denudò e le cavò gli occhi consegnandola ai parabolani che la
fecero letteralmente a pezzi usando dei gusci di conchiglia affilati.
Poi misero i suoi poveri resti in dei sacchi di iuta e li portarono
esultanti al Cinereon dove li bruciarono insieme alla
spazzatura.
Nessuno degli scritti di
Ipazia è giunto sino a noi.
Le analogie ed i
parallelismi tra la biografia di Santa Caterina e quella di Ipazia,
nonchè la scarsità di notizie storiche sulla santa (3) - mentre,
viceversa, le vicende di Ipazia sono ben documentate negli scritti
degli storici dell'epoca (cfr. Socrate scolastico, Historia
Ecclesiastica;
Damascio, Vita Isidori) – hanno
fatto pensare ad una "cristianizzazione" postuma della
figura della scienziata e filosofa alessandrina, che comunque morì
pagana, in quella di Santa Caterina.
Note:
(1) Per questa ragione, oltre alla ruota
dentata simbolo del martirio, la santa è a volte raffigurata con in
mano un'ampolla vitrea. Inoltre i monaci del monastero del Sinai a
lei dedicato distribuivano ai pellegrini fiale del liquore capitis
Sanctae Caterinae da usare a fini terapeutici. La cappella del
Tesoro di Palermo conserva una fiala del XII secolo che reca appunto
questa dicitura.
Santa Caterina con in mano l'ampolla vitrea
(2)
I Parabolani (dal greco Παράβολοι o
Παραβολᾶνοι,
che
deriva da παραβάλλεσθαι
τὴν ζωήν,
che significa letteralmente "coloro che rischiano la vita")
furono i membri di una confraternita cristiana
che nella Chiesa delle origini si dedicavano sotto giuramento alla
cura dei malati, specie degli appestati, e alla sepoltura dei morti,
sperando così di morire per Cristo.
La
confraternita nacque durante la peste di Alessandria sotto
l'episcopato di Dionisio di Alessandria (seconda metà del III
secolo). In questo evento sta la giustificazione del loro nome: essi
rischiarono la vita (παραβάλλεσθαι
τὴν ζωήν)
per esporsi a malattie contagiose. Oltre a svolgere opere di
misericordia
essi costituirono successivamente anche una milizia privata agli
ordini diretti del vescovo. All'epoca di Cirillo erano in numero di
circa seicento.
(3) Nel 1969 la
commemorazione della Santa venne soppressa dai revisori del
Calendario liturgico con questa motivazione: "Si elimina la
commemorazione di Santa Caterina, iscritta nel Calendario Romano del
secolo XIII. Non solo la Passione di Santa Caterina è interamente
leggendaria, ma sul suo conto non si può affermare nulla di sicuro”.